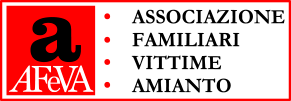SILVANA MOSSANO
E’ morta nel primo pomeriggio di mercoledì 11 settembre Romana Blasotti Pavesi. Aveva 95 anni, compiuti il 3 marzo scorso. Nel 1988 era stata nominata presidente dell’Afled (Associazione famigliari lavoratori Eternit deceduti) che, nel 1998, aveva modificato il nome in Afeva (Associazione famigliari e vittime amianto). Ha rivestito questo ruolo effettivo fino al 2015, mantenendo il titolo di presidente onoraria. Gli era subentrato Beppe Manfredi (morto di mesotelioma l’anno successivo), affiancato dal vice Giovanni Cappa (anch’egli affetto dalla stessa malattia, mancato nel 2020). Dal 2016 è presidente di Afeva Giuliana Busto, sorella di Piercarlo Busto, il Pica, noto atleta casalese stroncato dalla stessa patologia all’età di 33 anni. Romana Blasotti Pavesi era stata insignita dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica per il suo alto impegno nella ricerca della giustizia e della verità come presidente dell’Associazione di familiari e vittime amianto. Il rosario sarà recitato questa sera, giovedì 12 settembre, alle ore 19, a Casale Monferrato, nella Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria. Nella stessa chiesa, i funerali si svolgeranno domani, venerdì 13 settembre, alle 14,45. I consiglieri della coalizione civica «Casale davvero» hanno inoltrato al sindaco Emanuele Capra istanza di proclamare una giornata di lutto cittadino in occasione dei funerali: «Si tratta – scrivono nella richiesta, condivisa dal Pd cittadino – di una persona che è stata simbolo, in Italia e nel mondo, delle lotte all’amianto e che ha saputo comunicare alle generazioni più giovani con le sue intime sofferenze con spirito di resilienza e con una fortissima carica di positività ispirata da una sublime umanità». Il sindaco Capra e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Battista Filiberti hanno accolto la proposta: «Un’iniziativa doverosa che unisce trasversalmente tutte le forze politiche, le associazioni e le realtà cittadine». Domani, in occasione dell’inaugurazione della Festa del Vino, sarà osservato un minuto di silenzio.
«Vergognatevi! Noi siamo più tanti di voi!».
Lo urlò a tutta l’Italia, in quei giorni difficili e dolorosi in cui i casalesi si trovarono a fronteggiare una insidia perversa, quella che, all’epoca, su «La Stampa» avevo definito «l’offerta del diavolo». Reminiscenza del catechismo d’infanzia: «Il diavolo – ci aveva ammonito il parroco – si presenta sotto mentite spoglie, ti attira mostrando solo la parte bella e luccicante, ma, state attenti, è un inganno». E così quella offerta di denaro, avanzata dal maggiore imputato del maxiprocesso Eternit per tacitare la voce del Comune di Casale Monferrato, imponendogli la rinuncia alla costituzione di parte civile (cioè, di fatto, imponendogli di non rappresentare più, mai più, la collettività martoriata dall’amianto), mi era venuto di chiamarla così.
L’«offerta del diavolo» aveva scombussolato gli animi.
Quello della Romana era sconquassato. Non si dava pace. Anzi, era molto arrabbiata. «Lo svizzero ha fatto una cosa vergognosa: si è comportato nello stesso modo subdolo con cui l’amianto uccide le persone, colpendole a casaccio» aveva dichiarato a «La Stampa», alla vigilia della sentenza di primo grado.
Nel frattempo, il Comune aveva rivalutato le tentazioni iniziali e aveva respinto l’offerta. «Ringrazio il ministro della Salute Balduzzi e quella grossa parte di città che ha manifestato un profondo senso civico» disse Romana Blasotti Pavesi. «Se si fosse accettato, avrei provato personalmente vergogna a presentarmi ai magistrati che hanno lavorato tanti anni per arrivare a questo momento. Oggi invece provo orgoglio».
Della vicenda si erano interessati i media nazionali, giornali e tivù. Era il tardo autunno del 2011. Gad Lerner, il 20 dicembre, alla tempesta scatenata dall’«offerta del diavolo» aveva dedicato una puntata, ospiti in studio e collegamento esterno con un nutrito gruppo di casalesi. Romana era in prima fila. Le misero un microfono davanti. La voce tuonò: «Vergognatevi!», un’invettiva severa nei confronti di coloro che non erano contrari all’ipotesi di accettare il «patto». Lei gridò per tutti: per quelli che erano morti e per quelli che, da vivi, piangevano i loro morti, e per quelli che, se pur ancora vivi, erano già malati di mesotelioma.
«Noi» urlò da far vibrare l’aria, «siamo più tanti di voi!».
La dottoressa Daniela Degiovanni, che ha condiviso con Romana decenni di vita, di lotta, di confidenze, le strinse un braccio. Confidò, più tardi: «Temevo le venisse un infarto».
La voce stentorea era uno dei caratteri distintivi della Romana, insieme agli occhi celesti, che sapevano essere luminosi come acquamarina o gelidi come ghiaccio, conficcati in un volto che la somma di sofferenze aveva trasformato in pietra scolpita.
Il cuore, poi, era fatto di una materia speciale, non saprei dire come, ma non avrebbe altrimenti potuto resistere alle bastonate inferte con accanimento dal destino. Lei stessa un giorno dichiarò: «Avevo persino pensato che la mia famiglia fosse vittima di un maleficio». Romana ha sepolto suo marito Mario, ex operaio dell’Eternit, nel 1983, sua sorella Libera, nel 1989, suo nipote Enrico Malavasi (50 anni, figlio di Libera), nel 2003, sua cugina Anna, e sua figlia Maria Rosa, nel 2004. Per tutti, un solo colpevole: l’amianto che ha figliato il mesotelioma.
E, all’inizio di quest’anno, ancora un lutto per Romana: anche il figlio Ottavio l’ha anticipata nell’Altrove.
Romana davanti allo stabilimento Eternit (prima che fosse bonificato e abbattuto), tra Bruno Pesce e Nicola Pondrano[/caption]
Era diventata presidente dell’Afeva, l’associazione casalese che riunisce famigliari e vittime dell’amianto, nel 1988. Era morto Mario e lei non riusciva a farsene una ragione: non del lutto, un fardello che si portava intimamente appresso senza esporlo per pudore e riservatezza; ciò di cui non riusciva a capacitarsi è che si morisse a causa del lavoro. E, come Mario, altri mariti, e mogli, e figli, e fratelli. Una ingiustizia insopportabile. Le proposero quel ruolo rappresentativo. Lei ci pensò un attimo, poi disse: «Io non so se sono in grado, ma, se mi aiutate, sono pronta a lottare». Lo fece, presidente per quasi trent’anni, con integrità e senza cedimenti, affiancata e sostenuta da quelli che lei chiamava i suoi angeli custodi: Bruno Pesce e Nicola Pondrano. Ascoltava, si documentava, leggeva molto, chiedeva conto. Dove c’era da andare, andava: a parlare, a testimoniare, a spronare. Soprattutto i ragazzi: «Noi» diceva, «siamo arrivati fin qui, e, badate, abbiamo fatto molto. Ma non è finita. Adesso tocca a voi continuare». Il suo monito severo: «Dovete farlo, fino a che non ci sarà giustizia!».
La casa di strada Cavalcavia, dove Romana abitava, con le bandiere ai balconi
Lo slogan «Eternit Giustizia» lo indossava con orgoglio: stampato sulla bandiera tricolore che sventolava sul suo terrazzo, in strada Cavalcavia, e sull’adesivo giallo appuntato sulla maglia.
La notte prima dell’udienza in cui il tribunale presieduto da Giuseppe Casalbore avrebbe letto il verdetto di primo grado del maxiprocesso Eternit, a Torino, la Romana era agitata. «Sono di carattere ottimista, ma non nascondo che l’ansia c’è» mi confidò, «ho preso alcune gocce di sonnifero». Ma reagì: «Non voglio lasciarmi prendere dalla paura, voglio pensare che sarà premiata la nostra attesa di giustizia. Chissà che finalmente io non riesca di nuovo a piangere».
Aveva smesso da tempo perché la scorta di lacrime si era esaurita del tutto quanto la figlia Maria Rosa le aveva confidato di essere anche lei «ammalata come papà». Mesotelioma. Che «era così bella Maria Rosa, e aveva bei capelli. Ed era così giovane». Quando morì aveva 50 anni. Lasciò un figlio Michele, a sua volta padre di Francesca, che ora ha dodici anni e che adora la nonna Romana che l’ha accudita fin da piccolina.
Al processo, Romana Blasotti Pavesi raccontò e la sua storia divenne patrimonio del mondo: in tutta Europa, in Brasile, negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone e financo nei villaggi dell’Amazzonia: «Romana sei grande, Romana sei forte» scrivevano laggiù. Il mondo conobbe quella storia emblematica che era la copia del dolore di centinaia, migliaia di altre vite analogamente spente dalla pouvri.
Prima del giorno in cui avrebbe testimoniato, in aula non poteva entrare, è la regola. E per alcune udienze, dunque, fu costretta a rimanere fuori, riusciva a sapere quel che accadeva dentro solo tramite il racconto di altri. Un’anima in pena, su e giù per i corridoi, un po’ seduta sulle panche a dare quiete alle gambe doloranti.
Romana stringe la mano alla Degio, in attesa del verdetto di primo grado, a Torino nel 2012[/caption]
Poi, il giorno di quel primo verdetto,13 febbraio 2012, si alzò in piedi e strinse la mano della Degio, l’oncologa Daniela Degiovanni che ha «visto» e curato tanti malati. Chiuse gli occhi, forse a sforzarsi di capire se tutto quel che si poteva fare si era fatto o forse a richiamare tutti i nomi e i volti cui aveva promesso di lottare per la giustizia.
Seguirono, negli anni a venire, il processo d’Appello e, poi, in Cassazione. Quel mattino a Roma non c’era solo l’ansia: Romana era inquieta. E, nel pomeriggio, quando ormai quel che s’era da dire s’era detto, nella lunga attesa si ammutolì.
Romana davanti alla Corte di Cassazione[/caption]
Eravamo sedute su una panca, un po’ defilata e scomoda, una accanto all’altra, in penombra, senza parole, gli occhi puntati al pavimento, ostinate a non lasciarci trascinare da nessuna tentazione di fare previsioni. A una cert’ora della sera, arrivò il segnale: ci chiamarono nella grande e sontuosa aula e la Corte di Cassazione si pronunciò per la prescrizione. Tutto cancellato. Seguirono subbuglio, voci indignate. La cercai nella confusione e la ritrovai, in piedi, in quell’angolo defilato che avevamo occupato nell’attesa. Aveva lo sguardo smarrito e asciutto. «Abbiamo lottato così tanto per arrivare a questo risultato?» sussurrò. Il figlio Ottavio la trascinò via perché era troppo provata. Il giorno dopo, con lucidità lei commentò: «La Cassazione ha deciso così perché non conosce la storia di Casale». Voleva dire che quei giudici, così lontani da qui, non conoscono la paura costante di ammalarsi, l’angoscia di chi si ammala, la sofferenza di chi rimane. E, tuttavia, non si sentì sconfitta: «Noi» disse risoluta, «noi abbiamo convinto il mondo che abbiamo ragione».
Ammaccata, ma non piegata. Alla sindaca Titti Palazzetti un giorno disse: «Quand’è che inauguriamo il parco al posto dello stabilimento? C’è voluto tanto tempo per bonificarlo e abbatterlo, adesso è ora di trasformarlo». C’eravamo state, insieme, nello stabilimento abbandonato e ancora in piedi, molti anni prima, in un imbrunire autunnale che rendeva ancor più lugubre il luogo. Eravamo un gruppetto, anche di sindacalisti, ex lavoratori e famigliari di lavoratori, insieme al dottor Luigi Mara che aveva chiesto e ottenuto il permesso di fare un sopralluogo. Indossavamo mascherine e tute bianche gonfie e fruscianti, sembravamo fantasmi immersi in una semioscurità verdognola. Qualcuno azionava una torcia che saettava sulle pareti o contro i vetri rotti. Romana voleva sapere dove aveva lavorato Mario, «qui c’era questo reparto» spiegava uno, «qui si faceva quest’altro» aggiungeva un altro. Lei insisteva per vedere il «Cremlino», un postaccio nel seminterrato, dove la polvere ti sembrava di mangiarla, non soltanto di respirarla. «Ecco, era lì» dissero quelli che ci avevano lavorato, «ci mandavano chi era in punizione, le “teste calde” che magari si erano lamentate per le condizioni di lavoro». E Romana si affacciò a un buco aperto nel pavimento che si perdeva in un fondo nero, fosco, senza respiro.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella stringe la mano a Romana Blasotti Pavesi al Parco Eternot[/caption]
La sindaca Palazzetti aveva promesso a Romana che il Parco Eternot sarebbe stato inaugurato. E così avvenne, a settembre 2016, con la benedizione laica del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel parco, oltre alla pista di atletica, ai prati e alle piante, alle panchine e ai giochi per i bambini, trovò spazio un monumento vivente, ideato dall’artista Gea Casolaro, il Vivaio della Davidia involucrata: le cosiddette «piante dei fazzoletti», costantemente curate da un gruppo di volontari, a cui si attinge ogni anno per assegnare il Premio Vivaio Eternot.
Romana, in prima fila, accanto a Giuliana Busto; alle loro spalle, la statua della ragazza con l’aquilone[/caption]
Fu inaugurato anche un altro monumento, opera dell’artista Italietta Carbone: raffigura una bambina che corre facendo alzare in volo un aquilone, simbolo di un’anima libera. Quella statua è per tutti «l’aquilone di Romana»: Romana, la ragazza slovena, arrivata diciassettenne a Casale, che, mantenendo il suo spirito libero e indomito, ha fatto tanta storia in questa città.
Rispettosa e gentile sempre (salutava e stringeva la mano ai difensori dell’imputato svizzero con garbo sincero, perché «siamo avversari, non nemici»), non ha mai abbassato lo sguardo, convinta e orgogliosa di portare avanti una giusta causa.
Avrebbe desiderato trovarsi faccia a faccia con l’imprenditore svizzero. «Vorrei guardarlo negli occhi e chiedergli perché…». Ma Stephan Schmidheiny non si è mai palesato. Se l’avesse fatto, se avesse trovato il coraggio di scrutare gli occhi celesti della Romana, avrebbe compreso qual è la sua unica via salvifica, la possibilità di riscatto: finanziare la cura. Può ancora farlo, da qualche parte Romana lo verrebbe a sapere e finalmente potrebbe piangere di sollievo, liberamente.